ENERGIA DELLA MENTE
EMPATIA E RICONOSCIMENTO
Come Edith Stein, ridefinendo il concetto di empatia, ci aiuta a riconoscere l’alterità dell’altro e a rispettarla.
Come il bisogno di riconoscimento può diventare “trappola mortale”, che ci impedisce di evolverci.
Il concetto di empatia è spesso interpretato con il mettersi al posto dell’altro, immedesimarsi, entrare nel vissuto dell’altro. Questo modo di concepirlo porta facilmente al burn out, al tracollo della capacità di continuare la relazione di cura e a forme depressive, in quanto l’immedesimazione stimola la rievocazione delle proprie sofferenze e talvolta anche sensi di colpa, nel caso in cui non si riesca a farlo sufficientemente bene. Questo modo di concepire l’empatia, è molto vicina alla spiegazione dei neuroni a specchio, che sollecitano comportamenti simili, per acquisizione inconscia e una forma di sovrapposizione, di immedesimazione nella situazione contingente dell’altro, di conseguenza piuttosto che incontrare l’altro, nella sua alterità, si cade nello stesso baratro, da cui si vorrebbe aiutare l’altro ad uscire.
Possiamo fare riferimento ad Edith Stein per comprendere un altro modo di intendere l’empatia, che permette di rispettare maggiormente l’altro.
Edith Stein era una filosofa tedesca, ebrea, che si convertì al cattolicesimo e si fece monaca tra le carmelitane scalze, senza negare la sua radice ebraica. Fu assistente del filosofo Husserl ma, in quanto donna, non poté fare carriera accademica, anche se fu riconosciuta come pensatrice cristiana. Si salvò nel periodo della razzia degli ebrei, essendo una filosofa conosciuta e amata, successivamente le venne offerta protezione, un rifugio in Svizzera, che in un primo momento accettò, ma poi decise di rifiutare, in quanto non avrebbe potuto coinvolgere la sorella. Decise quindi di rimanere nel Carmelo e finì con l’essere catturata con lei e condotta in campo di concentramento, dove morì molto giovane.
Secondo i suoi studi e le sue esperienze, ritiene che l’empatia sia un tema filosofico, della filosofia pratica, non un sentire dentro, in quanto se così fosse mancherebbe il movimento tra gli interlocutori coinvolti. Essa infatti non è un’esperienza unilaterale che riguarda solo chi sta empatizzando: chi empatizza può farlo perché la sua interiorità è sollecitata da qualcosa che è offerto dall’altro, la cui esperienza, crea un contraccolpo dentro di me e, nel momento in cui me ne rendo conto, ho un’intuizione del suo vissuto psichico contingente, nel silenzio della comunicazione verbale, ma nella comunicazione tra invisibili differenti. L’empatia dice la verità di qualcosa di quel momento, il mio rendermi conto a distanza è reale, ma devo verificare, acquisire il consenso dell’altro all’adeguatezza dell’intuizione. L’intuizione non va infatti confusa con la conoscenza dell’altro, in quanto essa va convalidata dalla comunicazione. L’empatia, inoltre, non fa conoscere l’altro completamente, ma solo alcuni aspetti di lui, in un dato momento.
L’empatia si può dire sia già una forma di lavoro di cura, poiché la verifica dell’intuizione è riconoscimento e il riconoscimento dà benessere. Un altro diverso dalla madre riconosce chi sei tu in quel momento e accetta la realtà di quello che stai vivendo.
Un altro risponde al bisogno di essere visti, di essere riconosciuti, che l’altro e gli altri mi vedano, mi apprezzino, riconoscano il mio valore, il mio aspetto, le mie qualità. Al bisogno che l’altro e gli altri mi restituiscano, con i loro gesti e con le loro parole, quell’immagine che ho di me, quell’immagine che immagino di essere, quell’immagine che ho costruito e tento efficientemente di controllare e di preservare, spesso adeguandomi – come fosse un imperativo o un comandamento di un’imperscrutabile legge — al fascino imperioso di tante altre immagini diffusamente ammirate e riconosciute. Tanto più forte è il bisogno, tanto maggiore è la suscettibilità quando, anche per poco, quell’immagine non viene confermata, non viene restituita, come si vorrebbe.
Quando l’altro dice anche solo una parola o usa un’espressione che minaccia e mette in discussione quell’immagine, diventa un’offesa, un insulto, contro cui, subito e d’impulso, reagiamo e protestiamo. L’altro - non vedendomi come voglio essere visto, non dicendomi quello che voglio che mi dica - mi offende, mi calpesta, lede il mio bisogno e il mio diritto di essere visto. E al sentimento di essere offesi si accompagnano, subito dopo, e quanto spesso, il mood depressivo dell’inadeguatezza, il senso di sconfitta, la mossa contraria di nascondersi, di sottrarsi, il buio in cui nulla sembra avere più senso. Il buio e il dubbio di non esistere e di non essere. Il buio e il dubbio che la mia vita non sia, o sia un fallimento.
Certo un bambino, che muove i suoi primi passi incontro al mondo, ha bisogno di essere visto, ha bisogno di essere riconosciuto e sorretto dall’amore di uno sguardo, che gli restituisca e gli doni un’immagine in cui essere e attraverso cui definirsi. Non riuscirebbe a camminare, non riuscirebbe a parlare, se non ci fosse quello sguardo a vederlo e a rassicurarlo. A farlo essere. È l’inizio di un percorso, di un’elaborazione. Ma, per l’appunto, un inizio, una fase, una tappa.
Il disastro è quando continuiamo, oltre il tempo e la misura necessaria, ad essere ancora lì, comportandoci e reagendo allo stesso modo, senza peraltro più la grazia e l’innocenza dell’infanzia. Tristi mendicanti di uno sguardo che corrisponda all’immagine di quell’“io” che ci rappresenterebbe, di quell’“io” che supponiamo sia la nostra identità.
E tanto più, come oggi spesso accade, pensiamo di essere fluidi nell’identità, quanto più, con splendida ironia, siamo di fatto rigidissimi nella pretesa di essere riconosciuti.
Parliamo di decostruzione dell’identità, di decostruzione degli obblighi storicamente determinati, di voler essere in un certo modo, piuttosto che in un altro. Pratica salutare e necessaria, ma limitata, se è solo un discorso astratto, se sono solo parole che toccano la ragione discorsiva, e non anche quell’abisso ben più profondo che ci abita.
Di fatto, abbiamo una terribile paura delle ferite e di essere feriti. Ne abbiamo orrore e cerchiamo subito di medicarle. Siamo preoccupatissimi di prevenirle e di trovare garanzie o compensazioni al loro accadere. Cerchiamo subito di chiudere lo squarcio, di fermare il sangue, di tappare la falla. Eppure quel liquido rosso che sgorga dalle ferite è anch’esso vita. È anch’esso la vita preziosa che noi siamo.
C’è uno splendore delle ferite. Uno splendore che ci chiama ad attraversare, sia pure nello sconcerto e nello smarrimento, una soglia.
A fare un passo che non avremmo mai pensato, ad accedere ad altro ancora, che non avremmo forse mai sentito o sospettato.
Il taglio di una ferita — se non arretriamo subito e non cerchiamo l’immediata anestesia — è anche un dono che ci porta oltre.
Il dono di una soglia, al di là della quale altri inizi e altre promesse sono possibili.

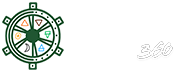
Commenti
Complimenti Mariella e Domenico